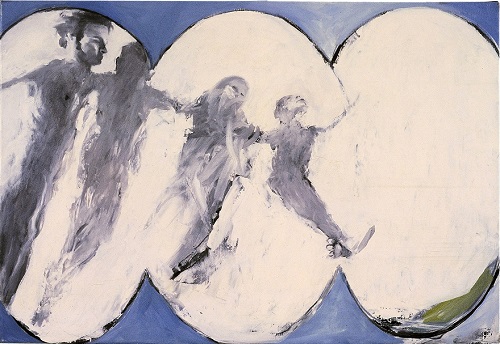L’esplosione della questione dazi non deve distoglierci dal tema cruciale della sicurezza europea, affinché gli eventi non si saldino in un caos non solo incontrollabile, ma anche difficile da commentare. Sul tema della sicurezza, non ci si può limitare alle evoluzioni del giorno; bisognerebbe piuttosto guardare alle cose con un minimo di profondità, e anche da prospettive diverse da quelle che ci piacciono. L’iniziale aggregazione dei paesi dell’Europa occidentale, certamente frutto delle nobili visioni politiche di Spinelli, Rossi e Colorni, e delle illuminate decisioni di Adenauer, De Gasperi e Schuman, fu anche voluta dagli americani per imbrigliare i paesi europei usciti sconfitti dalla guerra e prevenire così il possibile nuovo insorgere dei tradizionali attriti in un’area finita di fatto sotto loro interesse e controllo (malgrado le apparenze, anche Regno Unito e Francia sono da annoverare fra gli sconfitti, perché persero lo status di autonoma significativa potenza). Se l’Alleanza Atlantica raccoglieva i paesi euro-occidentali in chiave di difesa, le istituzioni europee li raccoglievano in chiave di collaborazione economica. In seguito, e soprattutto dopo la caduta dell’Unione Sovietica e i conseguenti allargamenti dell’Alleanza e dell’Unione Europea, quest’ultima è stata anche il “braccio disarmato” della NATO, contribuendo all’espansione dell’influenza occidentale, americana e atlantica verso territori un tempo rientranti nella sfera d’influenza russa. Se dobbiamo attenerci alle più recenti proposte della Commissione Europea, sembrerebbe che ora l’Unione stia diventando un “braccio armato”. La domanda è: braccio armato di chi? Non certo della NATO, che è armata di suo. Nemmeno dell’America, perché Washington non ne ha bisogno e si sta visibilmente allontanando da scenari e logiche europee. Sarà forse braccio armato di se stessa? No, perché essa non esiste come entità integra e omogenea.
La proposta di procedere a un grande riarmo dei paesi europei non rafforza l’Europa e non può essere considerata un gradino iniziale di difesa europea integrata. Avere i propri membri più armati non aumenta la coesione europea, soprattutto se proclamata in senso dichiaratamente antirusso, perché rischia di accrescere le divisioni fra paesi euro-orientali e nordici, animati da storica, profonda e bellicosa ostilità verso la Russia, e paesi che malgrado le condivisioni di maniera sono più lontani da quelle sensibilità, ritengono dopotutto di non avere motivi per medesimo astio o timore, e certo non escludono di riprendere con Mosca regolari rapporti. La proposta di riarmo dell’Unione va di pari passo con il solenne impegno a sostenere militarmente l’Ucraina “finché sarà necessario”; espressione disgustosamente ambigua che non significa niente, ma che, nel coacervo delle dichiarazioni e delle decisioni europee, va interpretata nel senso del perseguimento di una “pace giusta”. Purtroppo, però, le guerre non sono mai finite con “paci giuste”, anche perché questo non è un concetto assoluto, essendo piuttosto suscettibile di essere visto in modo rispettivamente diverso dalle opposte parti. In definitiva è un concetto più propagandistico che sostanziale. Alla fine di una guerra, c’è sempre chi ha vinto e chi ha perso, nelle varie declinazioni in cui si può leggere una vittoria o una sconfitta. La pace giusta è solo una: quella che discende dalla trattazione diplomatica dei problemi, dall’equilibrio fra potenze, dalla condivisione della sicurezza, dal reciproco riconoscimento, dalle mutue garanzie, dal contenimento del pur necessario strumento militare, dallo sviluppo del dialogo. Questi fattori possono prevenire ed evitare le guerre, oppure possono ricostruire la pace alla loro conclusione; purché si riconosca la sconfitta, non si perpetuino stragi e devastazioni senza alcuna possibilità di risultato, si elaborino visioni profonde sulle relazioni fra paesi e fra potenze, e si riportino al negoziato i problemi e i nodi che hanno scatenato il conflitto. Tutto questo comporta dolore, compromessi, lunghe e talvolta estenuanti trattative; anche necessità di accettare imposizioni, perché non sempre si può negoziare in condizioni di parità.
Entro questi termini si evidenziano i numerosi fallimenti dell’Unione Europea negli ultimi decenni, da quando abbandonò l’approccio dialogante che pure si era aperto nell’era Gorbačëv per schierarsi acriticamente sulla logica dell’autoreferenziale allargamento della NATO a guida americana verso le frontiere della Russia; non la casa comune “da Vancouver a Vladivostock” auspicata dallo storico leader russo, in effetti, ma la progressiva e rovinosa caduta da Helsinki al Donbass. L’Europa ha mancato tante occasioni di crescita, di coesione e di elaborazione di un ruolo internazionale non marginale: avrebbe potuto cercare di resistere (anche se non era facile) alla spinta per l’allargamenti della NATO; avrebbe potuto promuovere con più forza di quanto pure si tentò un’identità specificamente europea entro l’Alleanza Atlantica; avrebbe potuto lanciare parole e programmi di pace e di arresto dei combattimenti alla vigilia o all’inizio della guerra in Ucraina. Avrebbe potuto infine, in qualsiasi momento di questo lungo trentennio, riportare l’accento sull’esigenza di concepire la sicurezza europea in termini collettivi, valorizzando, in alternativa a quelle della NATO, le logiche e gli strumenti dell’OSCE[1].
Certamente l’Europa non aveva, e non ha, la forza militare né la coesione politica per imporre tutto questo; ma avrebbe acquisito almeno un’autorevolezza in grado di consentirle un ruolo di interlocutore, negli anni e ora, nel momento in cui si stanno perseguendo ipotesi di cessazione del conflitto in Ucraina. Avrebbe potuto ancora adesso, nonostante tutto, recuperare un po’ del tempo e dei possibili messaggi politici dispersi negli ultimi trent’anni, al fine di riacquistare un minimo di credibilità. Invece ha prodotto i cinque tardivi punti emersi dall’ultimo vertice e l’accordo per una militarizzazione onerosa, rischiosa e priva di progetto. La dichiarazione del Consiglio Europeo straordinario di Bruxelles dello scorso 6 marzo, approvata a ventisei senza il consenso dell’ungherese Viktor Orban, conferma i principi in cui gli europei si riconoscono per arrivare a una “pace giusta” in Ucraina: a) non possono esservi negoziati sull’Ucraina senza l’Ucraina; b) non possono esservi negoziati che interessano la sicurezza europea senza il coinvolgimento dell’Europa; c) qualsiasi tregua o cessate il fuoco può avvenire solo nell’ambito di un processo che porti a un accordo di pace globale; d) qualsiasi accordo di questo tipo deve essere accompagnato da solide e credibili garanzie di sicurezza per l’Ucraina che contribuiscano alla deterrenza di una futura aggressione russa; e) la pace deve rispettare l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Questi principi, che sarebbero stati degni di considerazione e suscettibili di influenza sull’andamento delle cose all’immediato inizio del conflitto, risultano oggi del tutto superati dagli eventi, considerata l’intenzione americana di metter fine alla guerra comunque sia, anche operando con qualche brutalità, e rischiano di apparire fuori tempo massimo e del tutto in contrasto con quello che, piaccia o meno, sta avvenendo. Oltre a non averne la forza, infatti, l’Europa non ha nemmeno l’autorevolezza per metterli con qualche speranza sul tavolo delle trattative, né su quello della guerra ove questa dovesse continuare ancora a lungo. Probabilmente Kiev, e forse l’Europa, compariranno nella fotografia conclusiva, se ci sarà, ma solo dopo che le decisioni siano state prese dai comprimari americano e russo. I principi di cui ai cinque punti avrebbero potuto forse avere qualche fortuna, ove sostenuti e più ampiamente modulati verso la metà degli anni Novanta oppure fermamente proclamati all’inizio della guerra. Oggi, purtroppo, si scontrano con una realtà certo sgradevole, alla quale tuttavia l’Europa ha contribuito con l’ignavia di decenni e con le cieche posizioni adottate all’inizio del conflitto armato.
Il riarmo proposto da Von der Leyen soffre della stessa decennale ignavia. La difesa comune europea è un tema importante, cui si sarebbe dovuto pensare già a partire dalla fine della guerra fredda, perché sin da allora era chiaro che gli orientamenti americani di sicurezza si sarebbero progressivamente allontanati dall’Europa (gli assertivi atteggiamenti trumpiani non sono che l’accelerazione di un processo cominciato da tempo). La difesa comune, però, non è una semplice questione di quanto investire in armamenti, ma di come collaborare tra paesi membri, stati maggiori, industrie militari; di quali strutture intergovernative o comunitarie istituire per la gestione della difesa; di quale concetto strategico adottare; di come affrancarsi dalle forniture americane facendo crescere una solida e collettiva ricerca e una comune produzione europea. Ma soprattutto bisognerebbe sapere e decidere al servizio di che cosa sarà messa la difesa europea: di un’Europa unita e coesa, o di una congerie di paesi diversamente uniti e spesso litigiosi? Paradossalmente gli investimenti preconizzati da Von der Leyen, che saranno su base esclusivamente nazionale, non avranno altro risultato, almeno per i prossimi anni, che quello incrementare gli acquisti di armamento americano e di vanificare del tutto la speranza di mantenere nel nostro continente una parvenza di stato sociale. Di più: l’Europa armata secondo le decisioni adottate a Bruxelles, viste le divisioni vigenti fra i membri e l’assenza, se non retoricamente proclamata, di una visione comune, rischia di essere ancora più debole, perché non è detto – finché non si elabori finalmente un vero e proprio disegno unificatore – che i vari membri metterebbero davvero a fattor comune le armi per fronteggiare insieme le crisi del futuro. Allora tanto varrebbe dire le cose come stanno: aumenteremo i bilanci militari, compreremo più armi dagli americani nella speranza (per ora non garantita) che non ci abbandonino del tutto, ci indebiteremo ulteriormente e faremo arricchire i fondi finanziari internazionali che gestiranno il risparmio privato destinato al finanziamento del riarmo. Non una grande visione. Non un grande progetto.
Certamente sulla situazione aleggiano sconvolgenti inquietudini, come appunto il timore dell’interruzione della copertura americana all’Alleanza Atlantica. A questo l’Europa si deve certo preparare, anzi, avrebbe dovuto già cominciare a prepararsi tempo fa. Ma la precipitazione di questi giorni non aiuta. Allora, ecco cinque punti alternativi a quelli del vertice straordinario che nella presente situazione sarebbero certo più produttivi di quelli attuali:
- a) l’Europa segue con realismo l’auspicata interruzione dei combattimenti in Ucraina e si impegna, a partire da tale interruzione, a dare inizio a un ampio dialogo con Stati Uniti, Russia e la stessa Ucraina al fine di elaborare un progetto di sicurezza collettiva in Europa, collettivamente garantito e volto all’equilibrio e alla pace;
- b) consapevole del ruolo che dovrà esercitare in futuro per la propria sicurezza e per i pacifici equilibri fra potenze e alleanze, l’Europa darà immediato inizio a un serio processo unitario in termini di politica generale e di difesa, anche su base parziale dei membri che intendano adottarlo;
- c) il rafforzamento della difesa europea, da elaborare sulla piattaforma della più ampia condivisione industriale e strategica, non sarà concepito contro alcun avversario che non manifesti intenzioni ostili, ma sarà da intendere come strumento di equilibrio politico e militare fra paesi e gruppi di paesi auspicabilmente interessati al pacifico svolgimento delle relazioni internazionali;
- d) pur nei meriti propri della difesa, l’Europa metterà lo strumento militare al servizio della diplomazia e dell’approccio negoziale alle relazioni internazionali;
- e) l’Europa, nel rispetto e nella riaffermazione dei propri principi istitutivi, persegue la pace e la collaborazione, nonché la necessaria unità d’intenti nella risoluzione dei problemi globali.
In un quadro del genere, che metterebbe insieme l’indispensabile realismo con la nobiltà dei principi, le necessità politiche e militari con l’avvio di un vero progetto unitario, il pragmatismo imposto dai fatti con la visione ideale, bisognerebbe subito avviare un dialogo con americani e russi. Senza l’arroganza della pulce, senza fantasie di interventi militari non accettati da tutte le parti, consapevoli dei minimi termini politici e della marginalità in cui l’Unione Europea è precipitata dopo decenni di insipienza; ma recuperando il bagaglio di idee, di principi, di attitudine al dialogo che pure l’Europa possiede e del quale ha talvolta dato prova. Anche perché, pur preparandoci al futuro, e visto che oramai gli avversari dell’Europa stanno di qua e di là, non possiamo che parlare con entrambi, per evitare di finire stritolati; a metterla sul piano del confronto armato o della deterrenza, e ammesso e non concesso che cominciamo subito a lavorarci, ci vorranno decenni. Molto più probabilmente, invece, se si conferma la linea Von der Leyen, ci ritroveremo con un’Europa a grave e pericoloso squilibrio di armamento nazionale fra i membri, animata da divergenti visioni di guerra e di pace, ulteriormente frammentata da incompatibili percezioni della potenziale minaccia.
Quando si è sbagliato tutto, sarebbe bene ammettere gli errori e ripensare a quali processi avviare per uscire dalla confusione. Goffi tentativi per riparare in pochi giorni agli sbagli di trent’anni aumentano lo sconcerto e incrinano ulteriormente la potenziale autorevolezza che l’Europa nonostante tutto meriterebbe e che deve assolutamente ricostruire. Non aiutano le dichiarazioni del Presidente Macron, secondo cui l’estensione all’Europa della protezione nucleare francese sarebbe affidata in ultima analisi non a un organismo collettivo ma alla decisione discrezionale dello stesso presidente della Francia. Non convince il “nuovo europeismo” del Regno Unito, il cui percorso storico è stato sempre quello di impedire qualunque crescita dell’Europa, anche interpretando questo proposito al servizio degli Stati Uniti, con i quali Londra ha un rapporto speciale cui non rinuncerà mai. Non rassicura il rafforzamento di una Polonia visceralmente animata dal desiderio di distruggere la Russia, la quale potrebbe trascinare l’intera Europa in una tragedia senza nome. Preoccupa, infine, l’istantaneo mutamento di rotta della Germania, che risulterà alla fine il solo paese europeo in grado di spendere a dismisura in armamenti, perché non oppressa da un debito troppo alto (osserviamo solo di passaggio, senza trarre conclusioni affrettate, che la potenza militare tedesca è stata all’origine di due guerre mondiali).
Eppure, per giustificare tutto questo, l’Europa si è inventata la minaccia di imminente aggressione da parte della Russia (e non solo: il Libro Bianco sulla difesa elaborato dalla Commissione europea menziona in tal senso anche Cina, Iran e Corea del Nord). Questo documento, oltre a un lungo preambolo in cui elenca gli elementi di instabilità dell’attuale situazione strategica come se questi non fossero noti da tempo e li scoprissimo invece solo oggi, lancia un allarme di assoluta e incombente emergenza bellica che non appare verosimile, almeno non nei termini evocati, ma soprattutto non appare chiaro; si può certo ipotizzare che ove Washington abandonasse effettivamente l’Europa al suo destino, magari in cambio della “comprensione” di Mosca sulla Groenlandia, e concedesse mano libera alla Russia, questa potrebbe essere tentata di insidiare prima o poi i Baltici o altri paesi in cui vivano proprie minoranze nazionali al fine di realizzare l’unione dei popoli russi. Ma anche in questo caso, che farebbe l’Europa, benché riarmata come intende il Libro Bianco? Non potrebbe che intervenire nello stesso modo in cui ha gestito la crisi ucraina: sanzioni, aiuti militari, dichiarazioni di poco effetto, addirittura malauguratamente su più d’un teatro bellico. Una guerra d’attrito su più fronti di durata indeterminata, come quella descritta da George Orwell in “1984”. Pura e distopica follia. E se in tale follia vi fosse del metodo, sarebbe ancora peggio.
Naturalmente, anche in vista di possibili scenari come questo, e con la finalità di prevenirli, più che affrontarli a cose fatte, l’Europa dovrà provvedere alla propria sicurezza; ma nei termini più sopra indicati e con una precedente o almeno simultanea costruzione unitaria o federale, e soprattutto corroborando le politiche di difesa con un dialogo diplomatico volto ad affrontare i temi di sicurezza collettiva e di tutela delle minoranze in chiave OSCE, non in chiave di contrapposizione. E inoltre tenendo conto della seguente riflessione: abbiamo considerato la guerra in Ucraina un “attacco all’Europa”, o l’inizio di un attacco all’Europa; ma l’Ucraina non è membro dell’Unione Europea, né della NATO; quindi, è europea quanto lo è la Russia. Non si tratta di una questione di lana caprina, soprattutto considerato che i concetti di “Europa”, “comunità atlantica”, “Occidente”, risultano oramai scissi, obsoleti e non più integrati in una coincidente nozione. Se il focolaio della crisi ucraina e le possibili crisi future venissero interpretati sotto questa angolazione, cioè non come una guerra “contro” l’Europa, ma come una guerra “dentro” l’Europa, ci si renderebbe finalmente conto che quella che è in gioco non è semplicemente la sicurezza dell’Ucraina, ma la sicurezza dell’intero continente europeo; e che gli strumenti per garantirla dovrebbero necessariamente essere diversi dalla pura e semplice confrontazione, da paranoici allarmi, dall’armamento scriteriato e senza visione; e contemplare finalmente un progetto di sicurezza collettiva e di generale collaborazione politica ed economica.
Considerato quanto sopra, appare inquietante creare una minaccia che non esiste e un “nemico” che, passata la tempesta ucraina, avrà tutto l’interesse a coltivare pacifiche relazioni economiche con il resto dell’Europa, perché avevamo finora attribuito questa strategia a regimi dittatoriali, fascisti e nazisti volti a giustificare politiche di potere e di collusione altrimenti indigeribili. Nel caso in essere, la precipitazione con cui stanno avvenendo le cose non serve le ragioni di un’autentica difesa europea, favorisce fondi e bolle finanziarie varie, accrescerà i proventi dell’industria militare, sottrarrà risorse allo stato sociale, offre a classi dirigenti marce e incapaci l’irragionevole e opportunistica illusione di stampelle che consentano loro di reggersi ancora in qualche modo pur nella malferma precarietà dei tempi.
Siamo decisamente al capolinea di un percorso fallito, e bisogna intraprenderne un altro. La vera forza non è basata solo sulle armi, per quanto queste siano indispensabili. Un’Europa forte dovrà essere coesa, anche socialmente, progressista, unita, o almeno federata, e aperta a relazioni pacifiche ed economiche, non chiusa in sindromi di guerra e di emergenza. Corrotte e irresponsabili classi dirigenti politiche, economiche, finanziarie, globalizzate, lobbyzzate, hanno del tutto vanificato l’iniziale progetto. Bisogna superare queste dirigenze e le assurde logiche che hanno imposto e stanno imponendo, affinché il sogno europeo che abbiamo coltivato per decenni non si trasformi in un incubo.
V’è urgente bisogno (questo sì che è davvero urgente) di un rinnovato manifesto per una nuova Europa, se vogliamo evitare che questa parola si riduca a pura espressione geografica, che il nostro continente venga declassato a semplice penisola asiatica, che il nostro solo ruolo possibile divenga quello della preda.
In copertina: AM Hoch, Four Breathers (1985), olio su carta montato su tela
[1] L’Organizzazione di Vienna associa cinquantasette stati di tre continenti (Nord America, Europa e Asia), comprende tutti i paesi europei, Stati Uniti e Russia, e interessa oltre un miliardo di persone; essa discende direttamente dal processo di Helsinki, e annovera fra le proprie missioni temi quali la prevenzione e risoluzione dei conflitti, la diplomazia preventiva, il controllo degli armamenti, la tutela delle minoranze, la gestione delle frontiere, la promozione della democrazia, del buongoverno e dell’ordine pubblico in paesi fragili o emersi da crisi, il controllo democratico delle elezioni, la promozione dei diritti dell’uomo, della libertà di stampa, dell’educazione dei giovani e dello stato di diritto, il contrasto al traffico di esseri umani e al terrorismo, la cooperazione nei settori economici e in quelli della sicurezza. Strumenti in grado di prevenire ogni guerra.