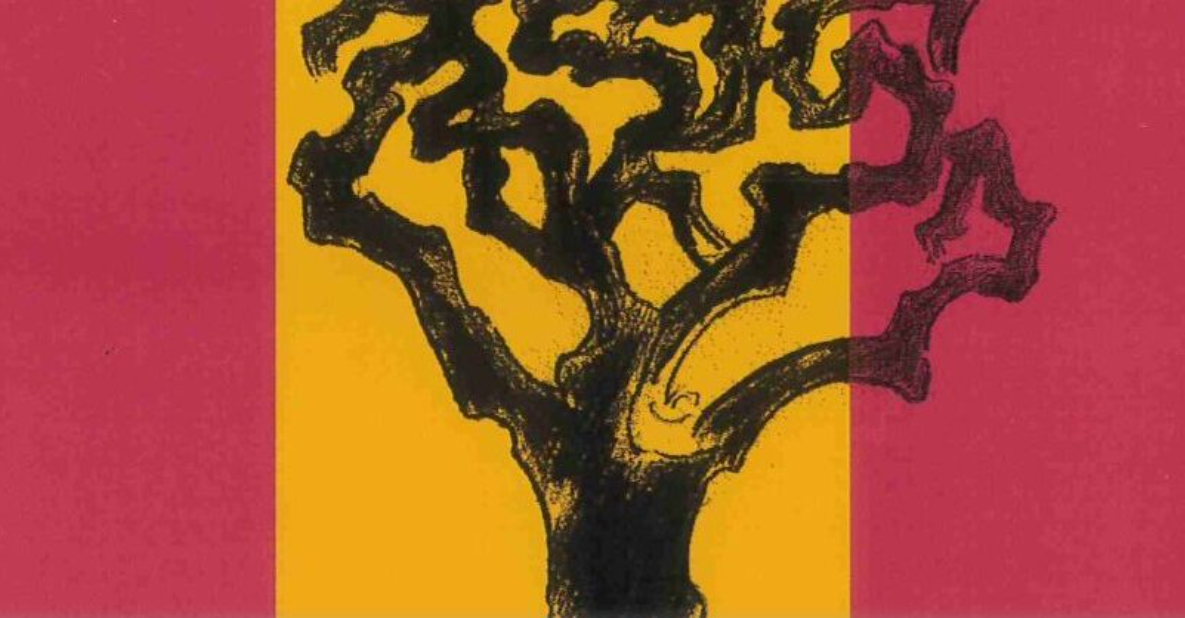N. Morra, Il messaggio di Levi e il Mezzogiorno. Tra diserzione della sinistra e Autonomia differenziata. Pref. di N. Filazzola, postfazione di G. Squame, con uno scritto di C. Levi. InfinitiMondi, Nola (Napoli) 2023, pp. 140.
Nando Morra, giornalista, sindacalista, noto esponente del PCI e poi del PD campano, riprende in questo testo il suo antico interesse per Carlo Levi, traendone spunto per un appassionato intervento, di stretta attualità e con forti accenti critici, sulla questione meridionale fino ai suoi più recenti sviluppi.
È noto che il capolavoro di Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, pur essendo uno dei classici più riconosciuti della letteratura meridionalista, ebbe un successo tutt’altro che incontrastato proprio nell’ambito del partito comunista, a cui pure Levi, che comunista certo non era, fu vicino in tanta parte della sua attività intellettuale e politica. Aspre, come ben si sa, furono le polemiche, soprattutto con Natoli e con Asor Rosa. Levi non credeva in una soluzione statalista, e tanto meno in una soluzione rivoluzionaria, della questione meridionale, che era allora essenzialmente questione contadina. La sua posizione appariva sentimentale, individualista, idealista, diciamo pure astratta e reazionaria. Pesava nella valutazione della sua opera l’ambiguità di fondo della posizione degli intellettuali comunisti o simpatizzanti del PCI verso il mondo contadino: da una parte valorizzato con sinceri sforzi solidali in quanto mondo di vinti e oppressi, ma sentito anche come arcaico, irrimediabilmente estraneo alla modernità, inaffidabile sotto il profilo delle lotte sociali, per certi versi addirittura nemico (esemplare in proposito la posizione di Ernesto De Martino). Carlo Levi, che i suoi contadini lucani li amava profondamente così come erano e non voleva “modernizzarli”, ma liberarli dall’oppressione dei “luigini”, la piccola borghesia parassitaria, secondo la celebre contrapposizione introdotta in un altro dei suoi testi narrativi più militanti, L’orologio, non era certo un campione dell’ortodossia marxista e appariva sostanzialmente estraneo alla posizione ufficiale del Partito e dei suoi intellettuali di riferimento riguardo alla questione meridionale.
Morra, invece, sposa incondizionatamente le posizioni di Levi, e nel riprendere e riattualizzare la vecchia polemica giunge quasi a contrapporre, con toni non di rado anche aspri, le istanze meridionaliste alla politica prima del PCI, poi del PD. C’è in proposito, al di là delle singole questioni specifiche, un notevole rischio, lo stesso in cui incorre tantissima parte della letteratura meridionalista attuale: quello di isolare la questione meridionale dal complesso delle questioni sociali del paese e di idealizzare il Sud come una sorta di società più o meno perfetta – comunque più giusta, più prospera, addirittura più moderna e avanzata – oppressa e saccheggiata dal Nord invasore e colonialista. Beninteso, Morra ci tiene a distinguersi dalle posizioni neoborboniche o comunque antiunitarie che rischiano oggi di diventare senso comune. E fa benissimo, a questo riguardo, a ricordare che il Meridione d’Italia ha dato un contributo notevolissimo, nei suoi intellettuali e nei suoi combattenti, alla causa unitaria, essendo del Risorgimento non vittima, ma protagonista.
“È stato significativo il contributo del Sud per conquistare cambiamenti politici e sociali e, in particolare, al Risorgimento. Una storia da sempre oscurata e sottovalutata. Come per l’indipendentismo siciliano nella lotta per la caduta di Francesco II. Nuclei di “carbonari”, aggregazioni come i Filadelfi e ridotti circoli di illuministi, hanno alimentato ideali e speranze nel tessuto sociale del profondo Sud. […]
Moti come a Potenza nel 1860, che si collegano e anticipano Garibaldi e i Mille. In Sicilia come a Matera, riprendono le lotte contadine per le terre demaniali. Costituirono terreno fertile per l’azione di Garibaldi che trova in Basilicata prima che altrove, le bandiere tricolori dell’Italia unita” (pp. 35-36).
Un altro spunto importante che distingue la posizione di Morra da tante rivendicazioni pseudomeridionaliste è il riconoscimento che nel mancato decollo economico e civile del Mezzogiorno sono numerose e importanti le responsabilità e le colpe della stessa società meridionale.
“La antica e storica responsabilità delle classi dirigenti meridionali con poche eccezioni, dai “baroni agrari” alla borghesia dei “tagliatori” di cedole, sempre pronti all’incasso ma restii agli investimenti produttivi manifatturieri e al “rischio di impresa” senza l’ombrello del protezionismo di Stato e dei contributi a “fondo perduto”, ha avuto e trova nefasta continuità nei tanti governi regionali, di tutti gli orientamenti politici, che si sono succeduti nelle regioni meridionali.
La conclamata incapacità di ideare, progettare e programmare mutamenti strutturali, anche nella riconversione delle aree industriali dismesse e di utilizzare la straordinaria opportunità dei Fondi UE, ha costituito un punto di caduta verticale del Sud che ha pagato, anche per questa via, il prezzo più alto della crisi prodotta dalla economia globalizzata, europea e nazionale” (pp. 72-73).
Nell’identificazione delle responsabilità politiche e culturali per il decollo parziale, contraddittorio e nel complesso insufficiente o mancato del Mezzogiorno, un tema di particolare importanza, che Morra affronta in maniera esplicita, energica e dura, riguarda le responsabilità della sinistra. È innegabile che, nonostante il personale impegno di numerose personalità illustri – una per tutte, Giuseppe Di Vittorio, ma l’elenco sarebbe assai lungo –, secondo l’ortodossia ideologica prima socialista e poi comunista, ai contadini del Sud non poteva essere riconosciuto altro ruolo che quello di alleati subordinati (e non del tutto affidabili) degli operai del Nord, soli possibili protagonisti del mutamento sociale. Successivamente, ha pesato in maniera assai rilevante un problema generale che le sinistre italiane ed europee sono ancora assai lontane dall’aver risolto, e cioè quale sia il ruolo sociale e politico e il compito storico di movimenti post-marxisti che dovunque hanno rinunciato a prospettive rivoluzionarie e dovunque hanno accettato come dati di fatto le regole fondamentali della società neoliberista. Sulle responsabilità individuali, poi, Morra è tutt’altro che tenero: D’Alema, Veltroni, Cofferati (particolarmente poco apprezzato da Morra, questi), infine più di ogni altro Renzi. Il giudizio complessivo è impietoso, forse persino troppo, eppure, pur nella mancanza di sfumature, nel complesso difficile da non condividere.
“La perdita di identità della sinistra ha un cammino visibile. Si concretizza lungo un percorso identificabile nella negativa interpretazione della necessaria modernizzazione e innovazione da introdurre nel rapporto tra produzione e lavoro e nella condizione sociale del paese. Per la sinistra culturale, politica e sindacale, si è tradotta nel cedimento progressivo sui diritti dei lavoratori e dei cittadini e sullo stato sociale; nella divaricazione ormai insostenibile tra profitti e salari; nel coprire sotto la cupola di una falsa modernità, forme generalizzate di lavoro precario e senza diritti che attanagliano milioni di giovani, donne e uomini, ai quali non è consentito costruirsi la certezza del futuro” (p. 92).
C’è però un punto in particolare, nella ricostruzione storica di Morra e nella sua proposta politica, che non appare del tutto convincente, ed è proprio lo sforzo di attualizzazione dell’insegnamento di Levi. Il Cristo di Levi ha un valore letterario indiscutibile, è una testimonianza umana di rara nobiltà e un’analisi antropologica che nulla cede in profondità alle ricerche che, più o meno negli stessi luoghi, avrebbe condotto pochi anni dopo Ernesto De Martino. Però parla di una società, una cultura e un’economia completamente diverse da quelle di oggi. La “civiltà contadina” oggetto del dolente amore di Levi, come poi di quello di Pasolini, è un mondo finito, non solo nel Mezzogiorno d’Italia ma in tutta Europa. E questo va compreso bene se non si vuole fraintendere – e spesso lo si fa – l’intera questione meridionale. Il fatto che tale questione sia all’ordine del giorno ancor oggi come centosessant’anni fa, non significa che sia rimasta la stessa identica questione. L’arretratezza del Sud non significa immobilità: infinite cose sono cambiate, e non poche anche in meglio – qualcuna, forse, purtroppo in peggio. Un cambiamento enorme, in particolare, riguarda proprio il punto centrale. Ai tempi dell’Unità d’Italia come ai tempi di Levi e oltre, ancora nel primo dopoguerra, la questione meridionale era essenzialmente questione contadina. Oggi non lo è più in nessun modo. Le campagne del Sud restano ancora in gran parte un luogo infernale, ma i dannati di quest’inferno non sono più gli stessi, e oggi la questione contadina si intreccia e in non piccola parte si identifica con la questione migratoria, non soltanto nel Sud. E a sfruttare il nuovo bracciantato in condizioni semischiaviste non sono solo i “luigini”, ma in non pochi casi i discendenti dei vecchi contadini.
Naturalmente, Morra vede benissimo che c’è stato un radicale mutamento, e ripropone Levi in un quadro sostanzialmente cambiato.
“L’analisi sociale e politica della società meridionale narrata da Levi nella sua opera più politica, L’Orologio, definisce la demarcazione politico-sociale tra “luigini” e “contadini”. […]
I contadini non hanno niente.
I contadini sono gli operai, gli artigiani, i medici, professionisti, artisti, tutti quelli che fanno le cose. […]
Nel terzo millennio, luigini, nel Sud e nel Paese, sono anche professionisti, intermediari, boiardi di Stato e istituzionali, concessionari di lidi balneari, commercianti senza regole, evasori fiscali, colletti bianchi supporto della criminalità, chi specula sui prezzi, ecc.
I nuovi contadini, l’immenso esercito del lavoro precario, dei senza diritti, dei giovani, donne e uomini, costretti a subire sfruttamento feroce per paghe da fame… i cinquantenni senza lavoro per dismissioni industriali, le fasce di vecchie e nuove povertà… ragazze e ragazzi con alto tasso di cultura e professionalità costretti alla emigrazione interna o all’estero per lavorare, gli immigrati…” (pp. 97-98).
Questo però significa che, ammesso che i “luigini” siano ancora “luigini” (e non sarebbe vero, anche i ceti sfruttatori e parassitari sono profondamente cambiati), di sicuro i “contadini” non sono più per nulla contadini, e quindi la categoria analitica che si cerca di applicare non è in realtà applicabile ma è solo un pur suggestivo espediente retorico che rischia però di risolversi in una non innocua distorsione della realtà.
Forse è tempo di smettere di pensare che il Sud sia una sorta di mondo diverso, con una storia tutta sua, un’identità antropologica specifica e una sua peculiare civiltà, misera ma carica di una dolente autenticità umana che altrove non ci sarebbe. La miseria non è civiltà e non merita di essere idealizzata, proprio per rispetto di coloro che l’hanno dovuta subire.
Forse è tempo di capire che la questione meridionale è un aspetto, certo con importanti specificità, di una questione nazionale al di fuori della quale non solo non è risolvibile, ma neppure è comprensibile, e che questa è parte importante di una questione europea, neanch’essa isolabile dal problema globale di una “civiltà” neoliberista che proprio nel momento di un apparente (e troppo supinamente accettato) trionfo universale mostra tutte le sue corde e rende chiara persino ai ciechi (tranne che ai ciechi volontari) la sua radicale incompatibilità con un’esistenza umana dignitosa. Forse il primo passo per una reale soluzione della questione meridionale consisterebbe nel cambiarle aggettivo…
Del resto, non è che Morra non veda e non denunci il vero problema, e in proposito non manca di proporre un’analisi lucidissima che appare da condividere totalmente.
“Di contro, la sclerosi della dialettica sociale sotto regimi autoritari, alimenta la conservazione e gli interessi esclusivi del trinomio finanza-industria-agricoltura. Che significa dominio dei fondi di investimento e delle multinazionali sulla società, sulla economia, sui cittadini. Del global sul local. Il punto di crisi è dunque nel sostanziale immobilismo e subalternità di questi ultimi decenni da parte della sinistra e dei Sindacati. Della sinistra in primo luogo, in progressiva, inesorabile “crisi di identità”. Il vuoto viene da lontano” (pp. 102-103).
Ma, se questa è la diagnosi, alla terapia non può giovare in nulla l’idealizzazione nostalgica di un passato di cui pure si sa benissimo che non giustifica particolari nostalgie e da cui non si possono trarre altri insegnamenti oltre a quello che bisogna lasciarselo alle spalle senza nessun rimpianto. Bisogna alzare lo sguardo ed esplorare più vasti orizzonti. Senza trascurare le memorie delle sofferenze passate e degli uomini, come Carlo Levi, che cercarono nobilmente di alleviarle. Ma senza farsi invischiare, tra rancore e nostalgia, in un passato che bisogna decidersi una buona volta a lasciar passare.