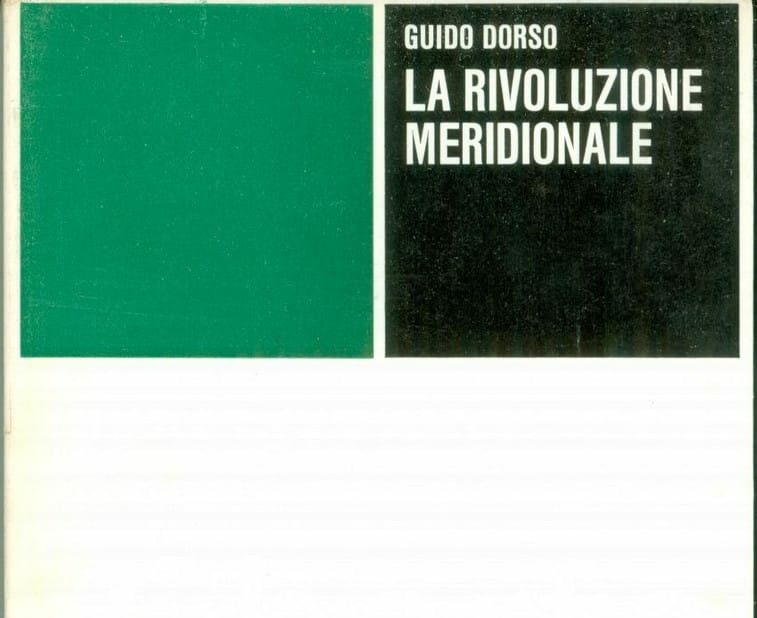“Questo lo ricordo, che stavamo in campagna, che io avevo fame e che mia madre mi dava l’uva fragola. E poi che una delle prime parole che ho imparato a dire è ‘tedeschi‘. Me la diceva mia madre”.
Elisa Dorso, 83 anni, per un trentennio amatissima insegnante di Filosofia al Liceo Sabin di Bologna, aveva due anni e mezzo quando ci furono i primi conflitti a fuoco tra i tedeschi e italiani ad Avellino, dopo l’8 settembre 1943. Suo padre Guido, il grande meridionalista, così ricordò quei giorni su ‘L’Azione’, periodico del Partito d’Azione con sede a Napoli, a due anni dagli eventi:
“Alle due antimeridiane del 9 settembre una colonna germanica si fermò sotto la mia abitazione. Sentii grida concitate e comandi brevi. Poi un colpo d’arma da fuoco ruppe il silenzio della notte […] Corsi a pigliare mia moglie e mia figlia, per trascinarle in luogo più sicuro. Barricai la casa ed attesi, con la morte nell’animo, che venisse l’alba.”
Dopo sei giorni – “.. sei giorni, il tempo sembrava interminabile!” – la famiglia Dorso sfollò in campagna. Ovviamente Elisa non ricorda quei giorni, troppo piccola per ricordare. Ma, quando le dico del gesto di suo padre, le risveglio alla mente quella consuetudine di Guido, quel suo tenerla in braccio quasi a proteggerla.
“Mio padre si rifiutava di portarmi in carrozzina, mi teneva sempre in braccio. Non portava la carrozzella perché magari si metteva ‘scuorno’; oppure forse non avevamo la carrozzella. Ero la sua unica figlia, avuta in età matura peraltro, e portavo il nome della sua adorata madre. Lo immagini un uomo di cinquant’anni che si trova in braccio una creatura ‘piccirella’ che si chiama come sua madre? Se sua madre si fosse chiamata Cunegonda io sarei stata Cunegonda Dorso. Mi avrebbe comunque dato il nome della madre, perché lui l’ha molto amata”.
Guido morì il 5 gennaio del ’47, non aveva ancora compiuto i 55 anni.
“Personalmente io di lui ho ricordi netti soltanto di quando stava già male, cioè degli ultimi sei mesi della sua vita. Mi ha avuto a quarantanove anni e quando è morto ne aveva 54. Sicuramente soffriva di angina pectoris e, quasi altrettanto certamente, è morto di enfisema. Questo quasi per certo. Perché chi lo vide morire diceva che che sembrava che stesse annegando. Il difetto cardiaco gli fu scoperto durante la Prima Guerra Mondiale. Aveva cominciato a fare la guerra come tenente, ed era al fronte. Lo congedarono quasi a forza per il difetto cardiaco. Quando nel ‘46 si aggravò, fu curato per sei mesi di stomaco, non di cuore. Non so se c’era una cura per farlo stare bene. Non ne ho la minima idea. Io lo ricordo solo a letto negli ultimi sei mesi”.
Dorso padre aveva da poco rotto con ‘L’Azione’, il giornale napoletano del PdA di cui era stato redattore dal ’45, e aspettava di trasferirsi a Firenze, dove Giorgio Spini gli aveva offerto la direzione de ‘La Nazione del Popolo’.
“Ma dovette dire che al momento non era in grado di assumere nessun incarico, perché non stava bene. Avrebbe fatto carte farse per andarci a Firenze, perché se ne voleva andare da Avellino. Questa è la cosa più sicura che ti posso dire”.
Elisa, tuo padre non coronò il desiderio di trasferirsi a Firenze. Tu invece ti sei trasferita presto a Bologna, perché questa scelta?
“Nel ‘70 vinsi il concorso a cattedra per l’insegnamento della Filosofia e il posto disponibile era al Liceo Sabin di Bologna. Non ci pensai due volte e mi ci trasferii. Per trent’anni vi ho insegnato. Ecco, la differenza è questa, ad Avellino io ero ‘la figlia di’. Non potevo che essere la figlia di Guido Dorso. E quindi tutti a dirmi: dovresti proseguire l’opera di tuo padre, tuo padre non avrebbe fatto così, avrebbe fatto cosà; tu stai facendo questo e quest’altro, ti stai sbagliando… Se c’è una ragione per cui io mi sono trasferita a Bologna è per essere Elisa Dorso, e non più la ‘figlia di Dorso’. Volevo essere me stessa, e lo sono stata. In questo modo onorando mio padre, secondo me, più di quanto non abbiano fatto i tanti ‘figli di’ che ho conosciuto in vita mia”.
Durante gli anni di quotidiano contatto con i ragazzi di Bologna, molti dei quali sono diventati poi esponenti della classe dirigente professionale e politica della città e, alcuni, dell’Italia, hai avuto modo di avvertire un mutamento dei sentimenti dei giovani verso il Mezzogiorno? Come consideravano cinquanta anni fa la questione meridionale? E oggi come considerano?
“L’hanno sempre considerata una questione locale, a loro interessa poco”.
Insisto: e fuori dal liceo, frequentando l’ambiente politico culturale di Bologna, vi hai notato un’oscillazione da una posizione solidale verso il Mezzogiorno a una chiusura in se stessi a partire dalla fine degli anni ‘80 inizi anni ‘90?
“Quindi sostanzialmente stai dicendo da quando muore il PCI. In realtà io non ho mai trovato particolare attenzione nei confronti della questione meridionale. Anche se ricordo una Festa de l’Unità dell’86. Arrivò Bassolino, lo ricordo benissimo. Doveva fare il discorso finale, quindi stavamo nel padiglione grande, quello dei dibattiti. E Bassolino disse: ‘Io mi sono reso conto del fatto che aveva perfettamente ragione Guido Dorso, avremmo dovuto, fin dall’inizio, assumere la questione meridionale come questione nazionale’. Che poi è anche il motivo per cui papà non aderì al PCI di Togliatti, il quale non assunse la questione meridionale come questione nazionale”.
Insomma, la lezione di tuo padre sulla ‘questione meridionale come questione nazionale’, che poi è la stessa di Giustino Fortunato, di Gaetano Salvemini, Manlio Rossi Doria e degli altri meridionalisti suoi coevi, non è mai entrata nell’animo dei bolognesi?
“Direi che sia proprio così. Io e te siamo stati insieme per parlare di questione meridionale, con Giuseppe Giliberti, lo scorso 6 febbraio alla Bolognina, sede storica del PCI ed oggi del Pd, il circolo dov’è iscritta Elly Schlein. Ricordi bene la scarsa partecipazione”.
Torniamo a Guido Dorso, Togliatti voleva portarlo nel partito comunista …
“Quello senz’altro. Abbiamo delle lettere di Togliatti. E papà non fu sordo a quella lusinga, non maturò però un’adesione al PCI, non ebbe il tempo di maturarla. Alla fine uscì solo dal Partito d’Azione”.
Quando uscì dal PdA?
“Fu nel ’45, quando gli chiusero il giornale ‘L’Azione’ di Napoli. Lui scrisse una lettera di dimissioni dolorosissima: mi sono illuso che fosse possibile trovare un partito che realizzasse le mie idee. E invece non è così, avete fatto solamente chiacchiere, eccetera. E se ne andò”.
Sarebbe col tempo arrivato al PCI?
“Non lo so se ci sarebbe arrivato. È forse probabile, ma questa è un’ipotesi lineare senza nessun riscontro. Più probabile che alla fine si sarebbe accostato al partito comunista come indipendente. Questo potrebbe essere, però non lo so. Io ho l’impressione che papà di politica ne capisse il giusto. Come diceva Vittorio Foa, lui era un poeta più più che un politico. Capiva il giusto, nel senso che l’unica cosa certa è che papà aveva capito la questione meridionale. ‘La rivoluzione meridionale’ rimane ancora adesso un libro di straziante attualità. Se ci pensi, ha fatto 100 anni quel libro ed è ancora attuale”.
Ancora un attimo sul rapporto con il PCI. Probabilmente il percorso sarebbe stato quello che dici, invece tu, Elisa, hai avuto una militanza nel PCI ed hai anche conosciuto e forse frequentato, perlomeno intellettualmente, Enrico Berlinguer.
“Sì. Io mi sono iscritta al partito comunista nel ‘76 e ho fatto la campagna elettorale ad Avellino nel ‘79, che c’era appunto Berlinguer. Quindi l’ho incrociato qualche volta, anzi addirittura una volta facemmo un’iniziativa assieme. Insomma, io stavo al suo seguito. Per me il PCI era la casa. Ecco, per me personalmente, non so per mio padre cosa sarebbe stato, ma era il posto giusto dove stare e dove lavorare, politicamente parlando. Sicuramente nel dopo la morte di Berlinguer tutto è cambiato, secondo me dolorosamente, anche se io ritengo che fosse necessario quello che ha fatto il Partito, cioè di dire dopo la caduta del muro di Berlino basta, noi siamo il Pds, non siamo più il PCI. Eppure io sono ancora orfana di quel PCI. Perché il PCI all’epoca era un posto molto bello dove stare. Si era protetti, si era d’accordo o in disaccordo, si discuteva su tutto, su tutte le cose necessarie. Se si aveva un problema si andava in sezione, si discuteva con gli altri compagni su quali erano le cose da fare, quali erano le soluzioni migliori”.
Secondo te tuo padre, avesse conosciuto Enrico Berlinguer, lo avrebbe considerato, diciamo, arruolabile tra i suoi 100 uomini d’acciaio?
“Io penso di sì, però io sono innamorata. Di mio padre e di Berlinguer” .
Elisa si commuove, si riprende:
“Non so cosa avrebbe fatto lui. Vedi, noi siamo sempre stati un partito socialdemocratico, è la verità; però non avevamo il coraggio di dircelo, perché eravamo legati con Mosca e tutte queste cose. Berlinguer ha cercato di staccarsi da Mosca e lo sappiamo. Ha subito un attentato a Sofia, nel ‘73, lo sapevo benissimo. Il povero Aldo Moro l’hanno ucciso per questo, perché cercava di fare il compromesso storico. A me pare di ricordare di aver letto una cosa di questo genere: Berlinguer si era rotto una gamba o non so cos’altro, era fermo e rileggendo i libri di Dorso si era convinto del compromesso storico. L’ho letto da qualche parte, non ricordo di preciso dove. Forse su ‘l’Unità’, perché all’epoca io compravo ‘l’Unità’, e sono sicura di aver letto questa cosa. Dove, come, quando non lo ricordo, ma l’ho letta.Comunque, certamente Berlinguer aveva letto i libri di Dorso e gli era venuta in mente la follia del compromesso storico, su cui aveva trovato l’appoggio di Aldo Moro. E Aldo Moro l’ann accis. Scusa se adesso sono brutale. Insomma, io sono convinta che sì, Enrico Berlinguer poteva essere uno dei 100 uomini d’acciaio di cui parla mio padre”.
Tuo padre fu, fin da giovane, molto critico nei confronti delle classi dirigenti del Mezzogiorno. Non erano le terre poco fertili e la natura ostile le cause dell’arretratezza del Mezzogiorno, ma la sua classe dirigente affetta da personalismo e di trasformismo. Ciò, senza per questo assolvere le politiche dei governi dell’Italia unita, volte a tutelare i privilegi antichi delle classi dirigenti del Sud al fine di comprarne il consenso. E a considerare i meridionali come meri consumatori dei prodotti dell’industria del Nord, quindi destinatari di sussidi, non di politiche industriali.
Guido Dorso nel 1925 aveva chiosato la ‘Rivoluzione liberale’ di Pietro Gobetti con la sua ‘Rivoluzione meridionale’: se non fosse stata ‘meridionale’, la rivoluzione alla quale pensava Gobetti, non sarebbe stata. Negli anni della maturità si differenziò anche da Antonio Gramsci, che immaginava un’alleanza tra classe operaia del Nord e contadini del Sud. Per Guido Dorso la classe operaia del Nord sul Mezzogiorno era in sintonia con la borghesia. Entrambe non assumevano la questione meridionale come la questione nazionale più rilevante.
“Certo, sì, decisamente. Questa tua affermazione, non solo la condivido, ma aggiungo che lui si era illuso che il Partito d’Azione potesse sopperire alla mancata acquisizione del Mezzogiorno come questione nazionale con l’azione dei suoi famosi cento uomini di acciaio. In realtà il Partito d’Azione si rivelò una delusione. Come diceva lui stesso: siamo un partito fatto di galloni senza truppe, abbiamo solo generali e nessun soldato”.
L’impressione è che Dorso, nella temperie del secondo dopoguerra, non comprese l’entrata nella scena politica dei due partiti popolari di massa, la DC e il PCI.
“Credo anche io che lui non avesse, per così dire, ben compreso cosa stesse accadendo in Italia dopo Yalta, con la divisione di campo netta fra Europa orientale ed Europa occidentale. Lui mi pare che pensasse ancora ai 100 uomini di acciaio che avrebbero potuto, diciamo, segnare la strada, il percorso, condurre il Mezzogiorno al riscatto. Ma sì, questo era impensabile”.
Elisa, tuo padre stigmatizzava i due vizi delle classi dirigenti del Mezzogiorno, personalismo e trasformismo. A tuo avviso è ancora questa la cifra della classe politica del Sud?
“Assolutamente. Sono assolutamente d’accordo con mio padre. E con te, a quanto pare mi pare di capire.Ti volevo dire un’altra cosa sola. Un’ultima cosa, lui era molto contrario alla politica dei sussidi nel Mezzogiorno. Diceva che i sussidi erano la maniera con cui lo Stato unitario, dopo aver conquistato il Sud, manteneva a galla le vecchie classi dominanti”.
A questo proposito ti vorrei chiedere se a tuo avviso il Reddito di Cittadinanza non sia stato una specie di sublimazione della politica dei sussidi.
“D’accordo con te. Dorso diceva che il Mezzogiorno non ha bisogno di carità ma di giustizia. Però, appunto, tutto questo lo doveva fare una classe dirigente degna di questo nome, che non c’era. Forse non ci sta neanche oggi. Intanto il binomio personalismo-trasformismo è diventato un costume nazionale, e anche oltre. Mo’ in Italia i partiti sono personalistici, cioè tutti stanno con la Meloni, oppure tutti stanno con la Schlein, o con questo o con quest’altro. Per quello che mi riguarda, io sto con la Schlein. Voglio molto bene a Elly, perché mi pare molto in gamba, molto determinata. Ma è pur sempre personalismo, per fortuna separato dal trasformismo. I personalismi vengono fuori quando non c’è più il movimento reale, autentico dal basso”.
Prima hai detto dello stato unitario che conquistò il Sud. È la tesi anche di tuo padre, che propugnava un forte autonomismo del Sud come condizione per far venir fuori una classe di dirigente in grado di guidare il territorio. Questa cosa potrebbe essere coerente con l’autonomia differenziata pensata oggi?
“La battaglia autonomista di papà? Anche questa forse era più poetica che reale. Lui era per il self agreement, come condizione per la nascita di un ceto dirigente degno di questo nome. L’autonomia differenziata che stanno proponendo oggi è tutt’altro; è che le le regioni ricche in Italia si tengono tutti i soldi. Che il Veneto si tiene i soldi suoi, la Lombardia i suoi e a noi non ci danno niente, io la vedo così. Non so mio padre come l’avrebbe visto, sicuramente io mi arrabbio moltissimo. Fatto sta che l’hanno approvata questa autonomia, come hanno approvato la separazione delle carriere dei magistrati. E mo’ anche il premierato. Questi si prendono tutti i poteri dello Stato e fanno quella cazzarola che vogliono, addirittura in politica estera. Non mi fare parlare per piacere, sta andando tutto in in confusione, in bordello. In questo momento aggiungi quel pazzo scatenato che sta in America.. Stamm a post! Stiamo vivendo un momento orribile, orribile, quindi figurati se possiamo sperare nella risoluzione della questione meridionale da parte di questo governo”.
Elisa, mi permetti? Mi piacciono i tuoi intercalari in vernacolo napoletano, vi trovo una sorta di orgoglio identitario, posso usarli nel testo?
“Certo, anche perché il nostro vernacolo è molto più efficace della lingua. Devi sapere che io nel 1986, qui a Bologna, ho organizzato un corso di lingua napoletana. Vi partecipò anche Giuseppe Giliberti. Ebbe un grande successo di pubblico e di critica. E io ne fui la star..”.
In copertina: particolare di Guido Dorso, La rivoluzione meridionale, Einaudi