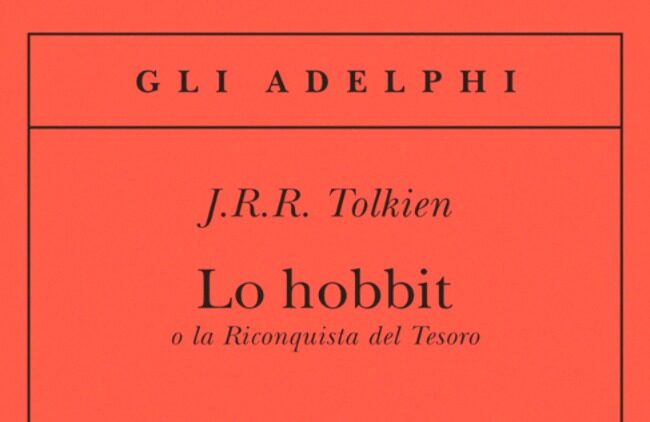Per raccontare questa storia, che si snoda per poco più di cinquant’anni, dobbiamo partire da due date precise. La prima, più vicina a noi, è il 16 Novembre 2023. Siamo a Roma, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna ed è la data di inaugurazione della mostra “TOLKIEN. Uomo, Professore, Autore”. Una inaugurazione a cui partecipa, oltre al Ministro della Cultura di allora, Gennaro Sangiuliano, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da sempre fan dichiarata dell’autore a cui è dedicata la mostra che visita in anteprima. “Una bella pagina di cultura” dichiara all’agenzia Adnkronos “una mostra molto bella e completa, ricca di molte cose che non conoscevo; una mostra molto viva che fa una ricostruzione molto bella non solo delle opere, che sono note, ma anche dell’uomo Tolkien. Quando studiavo la Letteratura, a me piaceva molto scoprire e capire cosa ci fosse nella vita dell’autore, perché aiuta a leggere meglio le sue opere. Questa è una mostra che, da questo punto di vista, fa un salto di qualità”.
L’altra estremità della nostra storia è a ritroso, nell’Ottobre del 1970 e siamo in una qualsiasi libreria italiana. E’ infatti appena uscita, per Rusconi Editore, la prima edizione del Signore degli Anelli nella nostra lingua. Tre anni prima, per la casa editrice Astrolabio-Ubaldini, era uscito il solo volume della Compagnia dell’Anello ma aveva avuto una diffusione a dir poco limitata (appena quattrocento copie). La prima edizione italiana del Signore degli Anelli ha l’introduzione di Elémire Zolla, anglista, comparatista e studioso della tradizione gnostica e iniziatica dell’Occidente[1], decisamente più nelle corde della destra piuttosto che della sinistra italiana. Sinistra che bolla il Signore degli Anelli come un libro fantasy e quindi passatempo per sciocchi, una fuga dalla realtà di un livello inferiore rispetto, ad esempio, al realismo borghese, trattandolo con superficiali e frettolose recensioni che lo stroncano. La destra italiana quindi trova campo libero in un mondo narrativo, simbolico e iconografico a cui rifarsi e di cui appropriarsi.
Tutto quello che c’è di Mezzo (perdonatemi il divertissement, visto il tema) è la Storia, volutamente con la S maiuscola, di Tolkien, e quindi del Signore degli Anelli, in Italia. Che, vi anticipo, è un caso unico al mondo di politicizzazione.
Perché parlarne
Un caso che è importante analizzare, rivedere, dibattere non per meri motivi letterali o di pseudo attribuzioni di campo politico, totalmente fuori contesto, ma perché credo che l’assioma Tolkien – destra stia diventando tremendamente potente ed è rivolto, soprattutto, alle giovani e giovanissime generazioni. Ed è del tutto arbitrario nonché culturalmente e filologicamente scorretto.
Complice anche il successo planetario delle riduzioni cinematografiche del Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, questo mantra rischia di diventare particolarmente penetrante presso il grande pubblico e quindi una breve analisi, certo non l’unica, sulla veridicità di questa vicinanza letteral-politica, credo sia ancora più doverosa. Curioso anche notare che nella serie successivamente prodotta da Amazon, Gli Anelli del Potere, si sia scatenata una contro rivolta da parte di ambienti legati alla destra, e in questo caso non solo italiana, per una presunta virata woke delle opere di Tolkien. Protesta legata alla scelta della produzione di Amazon di utilizzare attori ispanici o neri per interpretare alcuni elfi, tra le altre cose. Ma andiamo con ordine, passo passo. Perchè, come sappiamo bene noi avidi lettori tolkieniani, ogni storia, anche la più grande, inizia con un piccolo passo.
E ritorniamo al 1977, precisamente l’11 e 12 Giugno a Montesarchio, in provincia di Benevento. Quindi sette anni dopo la prima edizione italiana del Signore degli Anelli. In questo weekend si tiene il primo Campo Hobbit, manifestazione organizzata dal Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano. Questi eventi, a cui ne seguiranno ufficialmente altri tre nel corso degli anni, serviranno alla nuova generazione di missini, quella che non ha più contatti diretti con il ventennio, a rielaborare simboli e mitologie che non richiamino direttamente al fascismo e a trovare in Tolkien un modello, un nume tutelate a cui ispirarsi. La vecchia guardia del partito è a dir poco scettica sull’operazione che rimane quindi più o meno circoscritta al gruppo di giovani di allora. Che diventano poi, in larga misura, il gruppo dirigente di oggi di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni in testa.
Quantomeno curioso, invece, che negli Stati Uniti Tolkien fosse stato eretto a paladino dagli hippie e quindi appartenesse, in quel contesto, ad un mondo culturale e politico diametralmente opposto.
La sua figura, di inglese tradizionalista cattolico, che aveva sempre tenuto a distanza l’utopia socialista, era ben più che sufficiente per i giovani missini italiani a farne un simbolo.
Ma è doveroso sgombrare il campo da confusioni e tirate di giacchetta: Tolkien non è un autore di sinistra. Ma sicuramente neanche di destra. Tolkien è Tolkien. Sarebbe come cercare di affibbiare un colore politico alla Bibbia.
Ed è proprio Tolkien a metterci in guardia dalla tentazione di fare combaciare autore e opera, totalmente in contrasto con gli intenti della mostra romana come dichiarato all’inizio di questa storia e da alcune iniziali giustificazioni della vicinanza politica alla destra.
Una delle mie più radicate convinzioni è che investigare sulla biografia di un autore sia un modo inutile e sbagliato di accostarsi alle sue opere e specialmente a un’opera di arte narrativa, di cui lo scopo, proclamato dall’autore, era quello di divertire…Quando l’avranno letto (il libro) , molti lettori (suppongo) vorranno “criticarlo” e persino analizzarlo…Non che io condivida questa disposizione alla critica: come dovrebbe risultare chiaro dal (mio libro in cui c’è l’affermazione di) Gandalf : “Colui che rompe una cosa per scoprire com’è fatta ha abbandonato il sentiero della saggezza”.[2]
Certo, Tolkien non è la legge ed esprime un suo parere personale. Il tema sull’aderenza autore/opera è molto dibattuto, specialmente negli ultimi anni, cioè da quando i social media hanno dato potere immediato di espressione agli scrittori e alle scrittrici e quindi un filo quasi diretto con i lettori e le lettrici. In alcuni casi, come quello dell’autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, ad esempio le dichiarazioni su alcuni temi come l’identità di genere e sui diritti delle persone trans hanno fatto molto discutere. Ma anche nel passato, autori insospettabili, come L.F. Baum, autore di un libro per bambini universalmente noto come Il Meraviglioso Mago di Oz, si lasciò andare a dichiarazioni sui nativi americani che lui definì pubblicamente, in un editoriale sul Saturday Pioneer, “cani piagnucolosi” e di cui si augurava lo sterminio dopo il massacro di Wounded Knee. Altri tempi, certamente, ma come vediamo il dibattito sul tema può assumere dimensioni quasi bibliche.
I temi della appropriazione in una nuova lettura sul genere
Ritornando a Tolkien, al netto di una confusione di fondo nel rapporto con la destra italiana che risulta già evidente da questi primi passi, quali sarebbero i temi, le motivazioni, i contenuti che hanno spinto il Fronte della Gioventù ad abbracciare Tolkien come nume tutelare, come mito letterario e iconografico?
Credo che, dopo tante analisi e tanti anni passati da questa iniziale folgorazione politico/letteraria, vada fatta una precisa analisi sotto una lente d’ingrandimento nuova, che cerchi di analizzare questa storia con gli strumenti dello scrittore, dell’autore quale Tolkien era. E dei generi letterari.
Il Signore degli Anelli, come confermato da tutta l’opera di Tolkien legata alla Terra di Mezzo, è puramente epica. E ce lo dice lo stesso Tolkien quando ci racconta perché ha scritto il Signore degli Anelli e perché ha creato la Terra di Mezzo in una lettera del 1951:
Fin dall’inizio ero costernato dalla povertà della mia terra: non aveva storie veramente sue (legate alla sua lingua e al suo territorio) , non comunque del tipo che cercai e trovai nelle leggende di altre terre. C’era molto di greco, di celtico, di romanzo, germanico, scandinavo e finlandese (che mi influenzò molto) ; ma niente di inglese, tranne materiale impoverito all’interno di racconti e poesie popolari. Naturalmente c’era ed esiste tuttora il ciclo arturiano ma, pur nella sua potenza, è solo imperfettamente naturalizzato, legato alla terra di Britannia ma non all’inglese, e non rimpiazza quello di cui sentivo la mancanza[3].
E prosegue
Una volta avevo in mente di creare un corpo di leggende più o meno legate, che spaziasse dalla cosmogonia, più ampia, fino alla fiaba romantica, più terrena, che traeva il suo splendore dallo sfondo più vasto – da dedicare semplicemente all’Inghilterra, alla mia terra.[4]
Quindi è Tolkien stesso che ci indica che il Signore degli Anelli, con tutta la Terra di Mezzo, è il suo tentativo di creare una mitologia prettamente inglese di cui lui, filologo e docente di Oxford, sentiva profondamente e malinconicamente la mancanza.
Malinconicamente, non a caso. La malinconia è uno dei registri più cari a Tolkien. L’epica del Signore degli Anelli è un’epica al tramonto, ci racconta la fine di un’era, la fine degli Elfi sulla Terra di Mezzo. Un’epica che racconta la fine di un mondo e quindi l’avvento di uno nuovo. Sta finendo il tempo degli Elfi, sta iniziando il tempo degli Uomini.
Un’ epica nostalgica, il tramonto di un’era e di un genere narrativo. Potremmo, provocatoriamente, rinominarlo C’era una volta l’epica oppure C’erano una volta gli eroi, richiamando la poetica di Sergio Leone. E in realtà Tolkien compie, con l’epica tradizionale, la stessa operazione che Leone compie più tardi con il western, considerata non a caso l’epica moderna americana. La cambia, la trasforma, ne racconta il declino attraverso delle caratteristiche nuove, ben precise.
Primi fra tutti, i personaggi. Leone e Tolkien condividono la scelta di lavorare per umanizzare e superare la dicotomia buono/cattivo, alla base delle storie epiche in cui gli eroi sono senza macchia e senza paura e i cattivi decisamente cattivi. Tradizione poi proseguita nel western tradizionale americano, partendo ad esempio dai personaggi di John Wayne.
Ora gli eroi diventano umani, si assottigliano i contorni tra buono e cattivo e la granitica divisione diventa una coabitazione. Nessuno è irrimediabilmente buono o irrimediabilmente cattivo. Smeagol, che diventa Gollum, è uno dei casi più eclatanti. Il Biondo di Clint Eastwood nel capolavoro di Sergio Leone, assieme al Brutto e al Cattivo, chiudono il cerchio già aperto dalla trilogia del dollaro sempre su questa scia.
L’epica tradizionale muore e ne nasce una nuova in cui ai personaggi senza macchia e senza paura si sostituiscono gli eroi umani, con le loro debolezze e le loro fragilità.
E tutto questo ci porta in un nuovo approccio narrativo, apre, anzi spalanca, le porte alla modernità dei personaggi che oggi conosciamo. Senza questa operazione non avremmo avuto tante serie di successo, come ad esempio Dexter o Breaking Bad. Oppure Game of Thrones.
Sopravviene quindi una domanda: in che modalità il genere narrativo del Signore degli Anelli, cioè l’epica, diventa uno strumento di appropriazione culturale?
Attraverso la confusione, da chiarire ancora se voluta o praticata in buona fede, tra gli stilemi epici e i valori associati. Insomma, ben che vada la destra italiana ha letto male Tolkien. Oppure ci ha giocato sporco, prendendo a sostegno della propria tesi solo gli elementi utili.
Epica al tramonto
Se cerchiamo la definizione di epica sul dizionario Treccani, troveremo
Narrazione poetica di gesta eroiche, spesso leggendarie.
Altre definizioni aggiungono
Un tipo di narrazione in versi, ampia e articolata, di imprese eroiche di uomini eccezionali, definiti appunto eroi.
Ecco il cuore della identificazione della destra italiana in Tolkien. Gesta eroiche di uomini eccezionali. In un momento storico in cui serviva trovare nuove narrazioni che superassero quelle fasciste.
Senza scomodare il Superuomo di D’Annunzio, è evidente che durante il ventennio, ad esempio, la narrazione epica mussoliniana è stata costruita sullo stesso meccanismo. Uomini valorosi (ancora meglio Mussolini, uomo), straordinari, eroi che compiono gesta memorabili dimostrando coraggio e forza di volontà ferrea. Il prototipo del fascista perfetto.
Peccato che, come abbiamo appena visto, Tolkien scriva un’opera sulla morte dell’epica, sul tramonto dell’eroe senza macchia e senza paura che si trasforma in Frodo che, e qui penso di non fare spoiler a nessuno, fallisce la sua missione. Un eroe che toppa nel momento in cui deve dimostrare il suo valore, la sua straordinarietà. Frodo è un eroe umano che non ha la forza di volontà di fare quello per cui sta viaggiando da centinaia di pagine. Il nostro eroe, e non solo lui, fallisce la sua missione. E quindi decreta la fine dell’epica eroica classica.
Qui sta il grande malinteso di fondo della appropriazione culturale della destra italiana missina, e poi post missina, dell’opera di Tolkien. Aver cercato qualcosa, tra le briciole lasciate sul campo dalla cultura egemone di sinistra del periodo, da usare come mezzo identitario attorno a cui costruire una nuova narrazione politica e simbolica. E avere trovato un tesoro come il Signore degli Anelli, da subito piegato a usi e consumi della propria fazione.
E poi, chi sarebbe l’eroe senza macchia e senza paura, il condottiero, il superuomo del Signore degli Anelli a cui ispirarsi in questa poetica tanto cara alla destra? Frodo? Che razza di eroe sarebbe quello che, giunto al momento in cui dimostrare il suo valore, cede alla tentazione e fallisce? Aragorn? Il ramingo, Grampasso, che vivacchia come un viandante cencioso perché ha paura di essere ciò per cui è destinato ad essere? Il suo viaggio dell’eroe è quello di accettare quello che lui è. Niente più, niente meno. Gandalf? Che deve affondare con il Balrog, combattere e perire per poi ritornare, novella figura di Gesù Cristo per il cristiano Tolkien, per trovare sé stesso e la saggezza necessaria? Potremmo elencare uno a uno i personaggi principali del Signore degli Anelli e non trovare nemmeno un eroe adatto a questa estetica della destra.
Tolkien e i totalitarismi
Tra le altre cose, banalmente, Tolkien era profondamente contrario al nazismo. Amava la Germania, da cui arrivarono i suoi antenati, e per questo odiava profondamente Hitler.
Comunque in questa guerra io ho un bruciante risentimento privato, che mi renderebbe a 49 anni un soldato migliore di quanto non fossi a 22, contro quel dannato piccolo ignorante di Adolf Hitler (…). Sta rovinando, pervertendo, distruggendo, e rendendo per sempre maledetto quel nobile spirito nordico, supremo contributo all’Europa, che io ho sempre amato, e cercato di presentare in una giusta luce[5].
E anche la sua risposta alla casa editrice tedesca Rütten & Loening, in trattative per la traduzione de Lo Hobbit nel 1938, è molto eloquente. Tre anni dopo l’entrata in vigore delle Leggi di Norimberga, alla domanda dell’editore, per adeguarsi alle norme del Reich sulla sua certificazione di essere ariano, il Professore risponde così
Cari Signori,
grazie per la vostra lettera. […] Temo di non aver capito chiaramente che cosa intendete per arisch. Io non sono di origine ariana, cioè indo–iraniana; per quanto ne so, nessuno dei miei antenati parlava indostano, persiano, gitano o altri dialetti derivati. Ma se Voi volevate scoprire se sono di origine ebrea, posso solo rispondere che purtroppo non sembra che tra i miei antenati ci siano membri di quel popolo così dotato. Il mio bis–bis–nonno venne in Inghilterra dalla Germania nel diciottesimo secolo: la gran parte dei miei avi è quindi squisitamente inglese e io sono assolutamente inglese, il che dovrebbe bastare. Sono sempre stato solito, tuttavia, considerare il mio nome germanico con orgoglio e ho continuato a farlo anche durante il periodo dell’ultima; deplorevole guerra, durante la quale ho servito nell’esercito inglese. Non posso, tuttavia, trattenermi dall’osservare che se indagini così impertinenti e irrilevanti dovessero diventare la regola nelle questioni della letteratura, allora manca poco al giorno in cui un nome germanico non sarà più motivo di orgoglio.
La Vostra indagine è sicuramente dovuta all’obbligo di adeguarsi alla legge del Vostro paese, ma che questa debba anche essere applicata alle persone di un altro stato è scorretto anche se avesse (ma non ce l’ha) a che fare con i meriti del mio lavoro o con la sua idoneità alla pubblicazione, lavoro del quale sembravate soddisfatti anche senza saper nulla della mia Abstammung.
Confidando che troverete soddisfacente questa risposta,
rimango il Vostro fedele J.R.R. Tolkien[6].
Evidentemente queste opinioni così nette devono essere sfuggite a tutti coloro che hanno cercato di imporre una virata decisa a destra all’autore Tolkien.
Certo, Tolkien era anche decisamente contro il Comunismo e una certa area della critica letteraria è concorde sulla sovrapposizione tra la figura di Sauron e quella di Stalin.
Ma allora Tolkien di sinistra?
Ma verso la fine di questa storia, come prova provata di quanto sia facile e arbitrario cercare di bollare un libro come il Signore degli Anelli, voglio proporre un esperimento. Infatti, il Signore degli Anelli è un libro totalmente epico, come abbiamo visto, e ricco di temi che è un po’ come pescare un numero alla lotteria e vincere sempre. Basta sapere quale numero vogliamo estrarre.
Se si volesse attribuire l’opera di Tolkien, in particolare il Signore degli Anelli, all’ambito culturale e politico della sinistra, quali elementi invece si potrebbero utilizzare?
A costo di essere pedante, vi rammento che è un puro esercizio di stile, non è un tentativo di nuovo indirizzamento politico, peraltro sterile. Tolkien è Tolkien, non è né di destra né di sinistra.
Sicuramente, uno dei temi più potenti che si potrebbe usare è quello, molto presente all’interno del libro, della capacità di andare oltre le differenze. Ad esempio, la storia di Gimli e Legolas, due esponenti di razze (nani ed elfi) che atavicamente si odiano, finiscono per capirsi, conoscersi e diventare l’uno il migliore amico dell’altro. Ma è vero anche in generale. La capacità di andare oltre le proprie diversità degli Uomini che uniti riescono a dare un contributo essenziale alla vittoria finale ma che divisi finivano per farsi una lotta egoistica e puerile. In un mondo, come la Terra di Mezzo, decisamente policulturale e polilinguistico.
Oppure il tema legato all’ecologia che è forse l’unico tema che Tolkien, sempre netto a rifiutare allegorie del Signore degli Anelli, ha invece ammesso di aver inserito. E ce lo racconta direttamente lui in questa lettera:
In tutta la mia opera io prendo le parti degli alberi contro i loro nemici. Lothlórien è splendida perché lì gli alberi sono amati; da altre parti le foreste sono rappresentate mentre si risvegliano alla propria consapevolezza. La Vecchia Foresta era ostile alle creature bipedi a causa della memoria di molte offese subite. La foresta di Fangorn era antica e bella, ma all’epoca della storia piena di ostilità perché era minacciata da un nemico amante delle macchine. Bosco Atro era caduto sotto il dominio di un Potere che odiava tutti gli esseri viventi, ma fu restituito alla sua bellezza e prima della fine della storia divenne Boscoverde il Grande[7].
E vogliamo anche ricordare che cosa succede a Saruman, con le parole di Barbalbero, il capo dei Pastori di Alberi, gli Ent?
Credo di capire adesso che cosa stia combinando. Sta progettando di diventare una Potenza. Ha un cervello fatto di metallo e d’ingranaggi: nulla gl’importa di ciò che cresce, se non gli serve in un’occasione immediata[8].
La critica di Tolkien al capitalismo più sfrenato, a quello che con l’industria sacrifica la natura al progresso tecnologico è uno degli evidenti richiami del libro. E risuona tremendamente attuale con una attenta vocazione delle nuove generazioni. Non un nostalgico angolo di Eden, un paradiso terrestre, ma una natura vista come bene condiviso, di tutti, che quindi siamo tutti a dover contribuire a preservare. E chi cerca di sopraffarla con la forza, finisce come Saruman imprigionato nella sua Torre dagli Ent che si ribellano allo sfruttamento.
Sarebbero davvero tanti, volendo fare un’operazione di costruzione “ad arte” di una qualsiasi identità politica dell’opera di Tolkien, gli appigli a cui aggrapparsi per valorizzare una o l’altra opzione.
Ma rimane comunque l’idea di Tolkien, quella che lui stesso ci confessa
Le mie opinioni politiche inclinano sempre più verso l’anarchia intesa filosoficamente come abolizione di ogni controllo (non come uomini barbuti che lanciano bombe)[9].
Verso i Porti Grigi
Concedetemi un ultimo ragionamento sul cuore del Signore degli Anelli, sull’oggetto più piccolo ma potente, sul motore della storia: l’Anello.
L’Anello rappresenta il Potere, questo pare evidente. E in questa storia la Salvezza, cristianamente intesa da Tolkien, arriva tramite la distruzione del Potere. Vince chi sa rinunciare al Potere. Un Potere così seduttivo che è l’essenza stessa dell’Anello. Un Potere che viene distrutto, paradossalmente, proprio dall’impossibilità di rinunciarvi. E che finisce tra le grinfie di Gollum mentre brucia vivo ma felice tra le fiamme del Monte Fato. Che sicuramente non è un concetto politicamente di destra.
E, per dirla con le parole di Tolkien su Gollum e sul Potere dell’Anello
Per un attimo fugace, se uno dei dormienti l’avesse potuto vedere, avrebbe avuto l’impressione di mirare un vecchio hobbit stanco, logorato dagli anni che lo avevano trascinato assai oltre il suo tempo, lungi dagli amici e dai parenti, dai campi e dai fiumi della giovinezza, ormai nient’altro che un vecchio e pietoso relitto[10].
In copertina: particolare di J.R.R. Tolkien, Lo hobbit o la Riconquista del Tesoro, Gli Adelphi, 1989
[1]Monda e Simonelli, Tolkien, il signore della fantasia, Frassinelli 2002.
[2] JRR Tolkien, La realtà in trasparenza, Rusconi, Milano, 1990, pp.223 e sgg.
[3] Monda e Simonelli, Tolkien il signore della fantasia, Frassinelli 2002.
[4] JRR Tolkien, La realtà in trasparenza, Rusconi, Milano, 1990.
[5] Lettera 45, 1941, La realtà in trasparenza, Bompiani 2001.
[6] Lettera 30, 25 Luglio 1938 a Rutten und Loening Verlag.
[7] JRR Tolkien, Lettera n.339 al Direttore del Daily Telegraph del 30 Giugno 1972.
[8] JRR Tolkien, Il Signore degli Anelli.
[9] JRR Tolkien, La realtà in trasparenza, Lettera 52, Rusconi 1990.
[10] JRR Tolkien, Il Signore degli Anelli.